
Dare del «leccaculo» al capo può costare il posto. Lo dice la Cassazione civile-sezione lavoro che ha confermato il licenziamento di una donna risalente al 28 novembre 2018. I giudici, chiamati a valutare la legittimità del licenziamento, si erano divisi.
Il Tribunale di Catania l’aveva annullato ritenendolo «sproporzionato» ma la Corte d’Appello aveva dato torto ai magistrati di primo grado valutando l’epiteto una «giusta causa di licenziamento» sulla base del contratto nazionale del lavoro che prevede la massima sanzione nei casi di «litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro» e per «grave insubordinazione».
Nel ricorso in Cassazione contro il licenziamento, B.M.P., queste le iniziali della lavoratrice, aveva chiesto di considerare che il suo era stato un comportamento circoscritto a quell'episodio e che non avrebbe compromesso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario col capo «anche alla luce di elementi quali la longevità del rapporto di lavoro e l’asserito stato di disagio psicofisico della lavoratrice».
Ma la Cassazione, nell’ordinanza visionata dall’AGI, ha replicato che non c'erano prove di questo stato di disagio e ha sottolineato «il contesto in cui il licenziamento è stato pronunciato cioè la reazione a una disposizione del superiore gerarchico, la presenza di un’altra dipendente, che ne ha accentuato la gravità e la platealità e la sussistenza di un atteggiamento di sfida e disprezzo verso l’autorità». A pesare, nel ragionamento dei giudici, anche un precedente disciplinare a carico della donna nello stesso posto di lavoro.




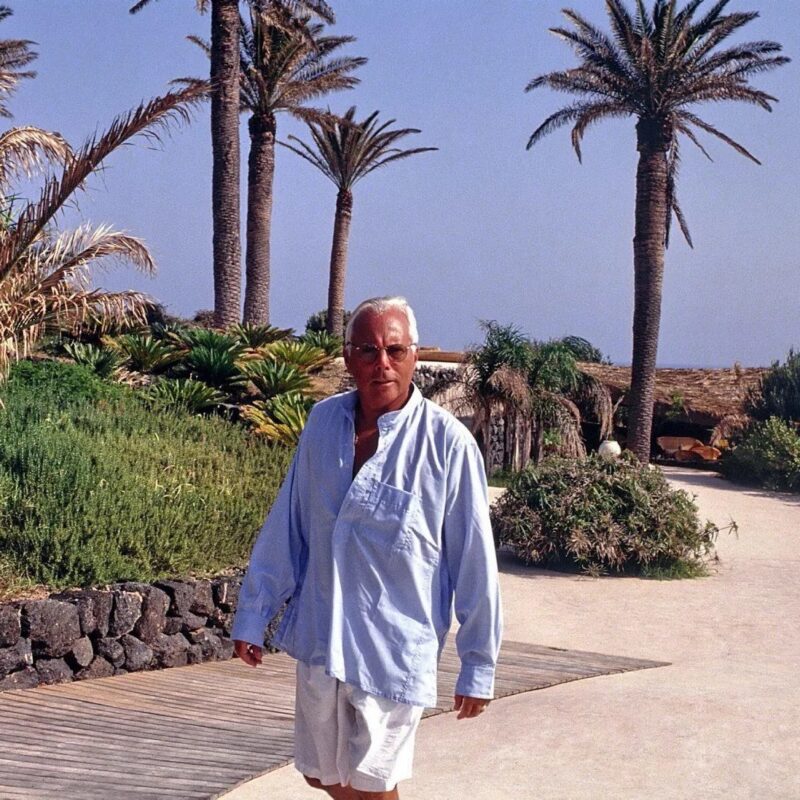


Caricamento commenti
Commenta la notizia